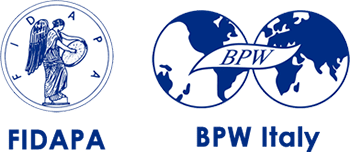“La nostra Terra si dovrebbe chiamare Mare”: queste sono state le parole con le quali ha iniziato la sua conferenza la dott.ssa Paola Del Negro, ricercatrice presso l’OGS di Trieste, nella sezione Oceonografia. Questo per sottolineare il fatto che la superficie del nostro pianeta è ricoperta per due terzi da mari e oceani, mossi continuamente dalle correnti. E la nostra sopravvivenza dipende proprio dall’acqua del mare, che è in grado di assorbire gli eccessi di anidride carbonica, che altrimenti renderebbero irrespirabile le nostra aria.
Di primaria importanza, dunque, è la salvaguardia degli ecosistemi marini, attualmente, purtroppo, pesantemente minacciati dall’aumento della temperatura, dalla pesca indisciplinata, dalla diffusione di specie aliene e dall’impatto dei rifiuti derivanti dalle attività umane.
Questi ultimi, in special modo, hanno dato origine a delle vere e proprie isole di plastica: due nel Pacifico, due nell’Atlantico e una nell’Oceano Indiano, innescando tutta una serie di problemi di difficilissima soluzione.
In particolare, la cosiddetta “Great Pacific Garbage Patch” è un’immensa massa di spazzatura che vaga nell’Oceano Pacifico: oltre 21 mila tonnellate di microplastica, in un’area di qualche milione di kmq.
L’accumulo è noto da parecchio tempo, perlomeno dalla fine degli anni ’80, e ha un’età di oltre 60 anni. Un gigantesco vortice di correnti superficiali ha concentrato in quest’area i rifiuti formati principalmente da materiali plastici gettati o persi da navi in transito, o scaricati in mare dalle coste del Nord America e dall’Asia. Questa concentrazione, oltre che dall’effetto focalizzante delle correnti, dipende dal fatto che la plastica non è biodegradabile e permane per tempi lunghissimi nell’ambiente. Una lentissima degradazione, a opera principalmente della luce del Sole, scompone i frammenti plastici in sottili filamenti caratteristici delle catene di polimeri. Questi residui non sono metabolizzabili dagli organismi, e finiscono per formare un vero e proprio “brodo” nell’acqua salata dell’oceano.
Gli effetti per l’ambiente sono ovviamente pesantissimi. Si pensa soprattutto alle alte concentrazioni di policlorobifenili, che possono entrare nella catena alimentare, visto che i filamenti plastici sono difficilmente distinguibili dal plancton e quindi ingeriti da organismi marini, ma anche alla capacità della microplastica di fornire un supporto alla proliferazione di colonie microbiche di patogeni. Più in generale, è preoccupante la presenza di rifiuti pervasivi e tossici, in un ecosistema fondamentale, durante periodi di decine o centinaia di anni.
A livello mondiale, sono quantomai urgenti, dunque, degli interventi che siano in grado, in qualche modo, di arrivare, se non alla risoluzione, almeno all’attenuazione del problema.
Ciascuno di noi, d’altra parte, potrebbe contribuire al miglioramento delle attuali condizioni dell’ecosistema marino attuando delle modifiche, anche piccole, al suo sistema di vita, se non altro seguendo la “regola delle tre R”: riduci, riusa, ricicla.
O vogliamo che le isole di plastica diventino la metafora del fallimento del nostro modello di sviluppo, che si preoccupa troppo poco dell’impatto delle nostre azioni sull’ambiente in cui viviamo?